Alle origini remote della fondazione dello S.C.R. credo ci sia un punto interrogativo.
Punto interrogativo che, una sera, sul finire dell’anno 1952, si presentò all’attenzione mia e di Giorgio Pasquini, all’epoca entrambi giovani soci del Circolo Speleologico Romano.
Nel grande salone di via Ulisse Aldrovandi, allora come oggi sede del glorioso sodalizio, attraeva infatti la nostra curiosità una cassettina di legno che, posta su un tavolino, conteneva ad uso di classificatore, un certo numero di schede, ognuna con pianta e notizie varie di grotte esplorate e conosciute.
Giorgio ed io eravamo reduci dalla campagna estiva del Circolo Speleologico, condotta nel luglio del ‘52 al Bussento e grotte limitrofe, sotto la guida di Carlo Franchetti ed eravamo naturalmente ansiosi di nuovi cimenti.
Cercando materia per le nostre velleità esplorative, cominciammo a consultare le schede in questione quando, sola fra tutte, una di esse ci fece trasalire.
Portava il nome di Grotta di Luppa ed il rilievo, ben disegnato, terminava con una bella galleria interrotta nel tracciato di pianta, come se il rilevatore o il disegnatore avessero improvvisamente cessato il loro lavoro.
La galleria pertanto doveva continuare ma, nel punto della sua logica, apparente prosecuzione, compariva, misterioso ed invitante, un bel punto interrogativo.
Da quel giorno, per quelle alterne ed imperscrutabili vicende della vita che, nell’immediato loro svolgimento, non lasciano trasparire tutto il loro significato e le loro conseguenze, quel punto interrogativo cominciò il suo lento lavoro “sotterraneo” che contribuì, come vedremo più avanti, alla fondazione nel 1959 dello Speleo Club Roma.
Nella scheda di quella, per noi ancora sconosciuta, Grotta di Luppa, al punto interrogativo si accompagnava la dicitura: “grande galleria alta m 35”.
Infine, nella pubblicazione di A. G. Segre sulla speleologia abruzzese, dalla quale la scheda era stata ricavata, la descrizione di quella cavità, relativamente al punto massimo raggiunto, finiva con la frase: “la galleria prosegue alta verso l’ignoto”. Non ci voleva altro per non farci stare più nella pelle.
Le indagini all’interno del Circolo non approdarono a nulla di concreto: sì, la grotta continuava, ma perchè, nel tracciato di pianta, il rilievo si interrompesse così stranamente, nessuno lo ricordava o lo sapeva. In realtà quello era il punto massimo raggiunto nella prima esplorazione da Carlo Franchetti nel 1929 e giustamente il rilievo terminava così.
In compenso tutti sapevano che l’inghiottitoio di Luppa era lo smaltimento di una valle carsica che, alla prima pioggia, si riempiva d’acqua ed il torrente che vi penetrava saliva immancabilmente di livello provocando pericolosissime piene.
Carlo Franchetti stesso era stato sorpreso da una di queste piene, nel suo tentativo del 1929, e solo per poco non finiva in tragedia.
Sapemmo anche subito che era una grotta molto impegnativa e che le possibilità di affrontarla si potevano prevedere solo con l’organizzazione di una grossa spedizione, con non meno di venti persone all’interno.
A queste se ne dovevano accompagnare altre all’esterno, dislocate sulla sommità dei colli e monti vicini, in contatto tra loro e con l’antro di ingresso, con il compito di scrutare il cielo ed avvisare tempestivamente sulla eventualità di nuvole foriere di pioggia.
Naturalmente all’interno lo svolgimento di un filo telefonico avrebbe consentito, in caso di pericolo, di avvisare i malcapitati che avrebbero dovuto abbandonare prontamente il fondo della galleria e guadagnare rifugi sicuri in parete, il più in alto possibile.
In effetti la precauzione del filo telefonico servì a far salvare la pelle al sottoscritto e a Mario Franchetti, figlio di Carlo, quando il 1° novembre 1958, fummo sorpresi dalla famosa temibile piena; ma ciò potrà essere argomento di un altro rapporto.

Luppa 1960
Riprendendo invece a raccontare quale fosse nel ‘52-’53 la posizione mia e di Giorgio in seno al Circolo, nei riguardi di Luppa, fu subito chiaro che, da parte del Consiglio direttivo, autorizzazioni per ricognizioni in quella grotta non ne avremmo avute.
A Luppa, o si procedeva con una organizzazione di grosso impegno per uomini e materiali, o non ci si pensava nemmeno!
D’altronde sul momento, i programmi del Circolo non prendevano in esame quella cavità: per l’estate del ‘53 era prevista l’esplorazione dell’abisso della Vettica; pertanto era bene che ci calmassimo e ci dedicassimo ad altre iniziative più concrete.
Ammesso poi che avessimo deciso di procedere per conto nostro, se pure i consiglieri responsabili dell’attività non potevano impedircelo fisicamente, certamente il materiale per Luppa non ce lo avrebbero dato mai: questa era la situazione!
Non avemmo dubbi: ci saremmo andati da soli e, per non creare sospetti con gli addetti ai materiali, decidemmo di cancellare Luppa dai nostri discorsi.
Al momento opportuno avremmo chiesto attrezzature per una banale uscita e saremmo partiti per la nostra avventura.
All’inizio dell’estate 1953 così avvenne; non ricordo che cosa inventammo nel compilare la scheda di prelevamento del materiale, fatto sta che ci fu dato e partimmo.
Avevamo un piccolo vantaggio, se non altro psicologico, da non sottovalutare per l’epoca: io ero a conoscenza dei luoghi.
Infatti ero stato alcuni anni in villeggiatura con la mia famiglia, poco dopo la guerra, a Tufo di Carsoli e per l’occasione avevo preceduto i tempi organizzando, nell’estate del ‘49, una minispedizione di ragazzetti all’Ovido di Pietrasecca.
Il primo saltino ci aveva fermati ma fummo ricompensati dalla scoperta della galleria delle vaschette: fu la mia prima grotta ed allora non sospettavo che esistesse un’attività speleologica tanto più organizzata in clubs o circoli.
Ma, tornando alla partenza per Luppa, il problema era come raggiungere Pietrasecca che, non possedendo macchine o moto, era per noi ai confini del mondo, per lo meno di quello raggiungibile “in giornata”.
C’era il treno fino a Carsoli e da lì gambe in spalla; oppure una corriera che però partiva da Roma di pomeriggio. Prendemmo quella ed arrivammo a Pietrasecca di sera.
Avevamo un carico complessivo di circa 70 kg, nel quale merita ricordare, oltre al resto, la presenza di due grosse scale costruite con gradini di legno lunghi 30 cm e cavetto d’acciaio di 5 mm di diametro, dal peso inusitato.
Sulla piazzetta di Pietrasecca fummo accolti dai presenti come oggi forse potrebbero essere accolti degli extraterrestri. Arrivare lì di sera, da Roma, per entrare nell’Ovido di Luppa di notte!
Ci salutarono con le loro benedizioni, certamente convinti che non eravamo del tutto sani di mente.
Da Pietrasecca a Luppa non c’erano strade, solo una mulattiera. Partimmo col nostro carico sulle spalle che, passo dopo passo, si fece sempre più pesante, perchè il tracciato che seguivamo passava attraverso un rado bosco, con una vegetazione bassa molto fitta, nella quale rimanevamo impigliati e sbilanciati.
Pensammo di migliorare la situazione approfittando di un lungo ramo sul quale appendemmo parte del materiale e le cui estremità mettemmo a spalla, secondo la migliore tradizione oleografica dei portatori africani.
Si approssimava lentamente l’imbrunire quando arrivammo sul limitare di un lungo campo coltivato ad erba medica: significava per noi la liberazione dai rovi, dai pruni, dai rami bassi degli alberi e dalle ginestre.
Era una sera limpida e l’alta valle di Luppa si apriva davanti a noi con i profili nitidi e puliti dei monti, nel cielo chiaro.
Il paesaggio emanava un senso di pace e di immobilità; ma la costa bruna del monte Guardia d’Orlando, incombente sulla destra, mandava sul prato un’ombra inquietante che lo divideva per lungo in due metà: una ancora illuminata dal sole del tramonto, l’altra già presaga della notte vicina.
Trasalimmo appena per una vaga impressione di isolamento e di lontananza da ogni aiuto; in effetti nessuno sapeva che fossimo lì.
Fu un attimo, attraversammo il campo e il vasto antro di ingresso dell’inghiottitoio di Luppa si aprì di fronte a noi.
Vi accedemmo. Eravamo nella zona d’ombra, ma l’intera vallata stava per entrarvi, che il sole scendeva veloce dietro l’ultima cresta.
Dalla soglia del grande portale vedemmo l’aria vibrare, attraversata da lunghe ombre violette, come se un gigantesco velario calasse ormai dietro di noi.
Non c’era tempo per i trasalimenti! Ci vestimmo, dimessamente come allora si poteva. Non avevamo stivali ma scarpette di tela a mezza strada tra le scarpe da tennis e le pedule; non avevamo mute di neoprene o simili, ma solo maglie di lana e una tuta militare mimetica per finire. Non avevamo guanti di gomma, cinture di sicurezza, discensori, lampade stagne e quanto altro caratterizza oggi l’attrezzatura media di uno speleologo, ma un cordino da roccia alla vita, con un buon moschettone, quello sì!
Eravamo i primi ad usarlo: non andava ancora di moda nella speleologia romana quel cordino di provenienza alpinistica, era anzi guardato con un misto di sospetto e commiserazione. Si adoperavano infatti larghe cinture di tela e cuoio normalmente in dotazione ai Vigili del Fuoco.
Entrammo che annottava e, per chi conosce Luppa, quello che riuscimmo a combinare durante la notte fu, a ripensarci con l’esperienza di oggi, un misto di ridicolo e di patetico.
Dopo una stretta galleria arrivammo ad un saltino dove armammo finalmente la nostra prima scala che smettemmo così di dover portare in spalla. Il saltino dava in una grossa marmitta piena d’acqua profonda: “il bicchiere”.
Evitammo di scendere in acqua proseguendo con una certa attenzione lateralmente, su rocce levigate, ed arrivammo ad un saloncino da dove partiva il secondo salto vero e proprio.
Nel frattempo Giorgio era riuscito a perdere una lampada elettrica che, sgusciata da una tasca della tuta, era finita, ormai imprendibile, nel “bicchiere”; per parte mia avevo reso inservibile, per un urtone maldestro, il beccuccio di una grossa lampada ad acetilene: la nostra quantità di luce si era ridotta di due terzi.
Armammo la seconda scala mediante l’uso di un canapone legato ad un masso e scendemmo il salto finendo in acqua fino alla vita.
Tutto questo ci aveva richiesto un tempo lunghissimo e un dispendio di energie con le quali oggi si riuscirebbe ad arrivare, forse, fino in fondo.
In effetti per le misure desunte dalla citata scheda, avevamo portato con noi scale e corde, ingombranti e pesanti, atte a superare un primo salto di 16 metri ed un secondo di 21.
In pratica due scaloni da 20 m ognuno e relative “capezze” (come chiamavamo in senso dispregiativo le grosse funi da sicura da 3 cm di diametro), tutte cose che ci avevano impegnato inutilmente, perchè il primo saltino risultò di soli 6-7 metri ed il secondo di una dozzina.
Sceso comunque questo secondo salto, trovammo che la galleria proseguiva completamente allagata con acque profonde.
Non avevamo previsto una simile eventualità; avremmo dovuto proseguire nuotando, ma come potevamo reggere tutto quel maledetto peso delle residue corde, scale e ferraglia che avevamo dietro? Fino alla vita eravamo disposti a bagnarci ma a farlo completamente avemmo qualche perplessità per il freddo e la stanchezza ormai incombente.
Avremmo avuto bisogno di un canotto di gomma ma, a parte il peso in aggiunta al resto, non ne avevamo immaginato l’impiego. Chissà perchè ma pensavamo che in qualche modo, in roccia, si potesse sempre passare.
Dopo un ultimo mesto sguardo alla galleria allagata che, stretta ed alta, si perdeva nell’oscurità, decidemmo di ripiegare e faticosamente lo facemmo, rammaricati per lo scarso rendimento che avevamo dimostrato.
Avevamo con noi la famosa scheda con il punto interrogativo, sottratta ormai da mesi dal classificatore, e ci rendemmo conto di aver conseguito solo un quarto del percorso che ci divideva dalla galleria “proseguente alta verso l’ignoto”. Che smacco!
Uscimmo che era giorno; le notti all’inizio dell’estate sono brevi ed il primo sole del mattino ci rinfrancò, ma era ormai troppo tardi per tornare a Pietrasecca a prendere la corriera che ripartiva per Roma molto presto.
Ci caricammo così sulle spalle tutto quel maledetto peso e, percorrendo in salita la valle di Luppa, ne superammo il crinale verso Est e scendemmo penosamente fino al paese di Sante Marie dove, nel pomeriggio, prendemmo un treno per Roma.
Per quell’anno la nostra disponibilità di tempo in ulteriori tentativi nell’inghiottitoio di Luppa era finita.
A parte gli impegni per gli esami universitari e a fine luglio i comuni programmi alpinistici all’Ortles e in Dolomiti, Giorgio doveva partire ai primi d’agosto per il corso allievi ufficiali a Lecce e il tutto fu rimandato al suo congedo.
Così fu e nell’estate del ‘55, dopo aver mantenuto nel frattempo un assoluto silenzio sulla precedente ricognizione, riprendemmo le operazioni per Luppa.
In verità avemmo nell’ambito del Circolo un appoggio insperato e affettuoso da parte del consigliere Marcello Cerruti, valente entomologo, che stimavamo moltissimo.
Giorgio ed io riscuotevamo la sua fiducia e la sua simpatia e proprio in quel periodo Cerruti era addetto all’attività.
Gli raccontammo quanto avevamo fatto nel ‘53 e lo mettemmo a parte delle nostre intenzioni.
Anche lui fu d’accordo di non parlarne ad altri, prese su di sè la responsabilità dell’iniziativa, si assicurò che non facessimo fesserie e ci consegnò l’agognato materiale che si risolse, in pratica, nelle sole scale.
Questa volta molte cose erano migliorate. Prima di tutto Giorgio aveva una Lambretta e con quella potevamo muoverci più liberamente; circa poi l’attrezzatura, le corde non erano più dei canaponi da 30 mm di diametro, ma normali, per l’epoca, corde da roccia in manila, personali.
Le scale erano le famose, per allora superleggere “Azario”, fatte comunque sempre con gradini di legno rinforzati alle estremità con ribattini in lamierino e munite di cavetti da 6 mm. In compenso erano larghe solo una ventina di centimetri, ma della loro “leggerezza” saremmo stati in grado di giudicare meglio qualche anno dopo.

Luppa 1960
Avevamo poi un piccolo canotto Pirelli, prestato da un amico, e per essere certi, con tutta l’acqua che allagava Luppa, di avere una sicurezza nella erogazione di luce, io mi procurai una grossa lampada che pesava da sola più di 5 kg e che era in dotazione alle navi della Marina Militare.
Lampada in struttura di alluminio, grossa quanto un vocabolario, assolutamente stagna e con una parabola di 12 cm di diametro.
La misi in uno zainetto che incollai sulle spalle insieme ad altro materiale; certamente ci dette sicurezza, ma le mie scapole se la ricordarono a lungo.
Partimmo per Pietrasecca a metà luglio. La Lambretta era talmente carica davanti, dietro e sui lati che, alla fine con noi sopra, a malapena se ne vedevano le ruote.
Questa volta non fummo costretti ad entrare al tramonto. Arrivammo a Pietrasecca di mattina presto; la stagione era più avanzata, la vegetazione più rada e le ginestre dai cespi opulenti di fiori luminosi spandevano un profumo dolce insieme ed amaro, che sopravanzava quelli più delicati e discreti delle rose di macchia, delle erbe, della terra, umide ancora.
Raggiungemmo Luppa più facilmente, grazie anche al carico più leggero e con grande determinazione cominciammo ad organizzarci per entrare la seconda volta.
In quei due anni che erano passati, Luppa era rimasta, nei nostri desideri e nelle nostre speranze, come un tormento.
Giorgio mi scriveva da Lecce durante il corso, poi da Caserta, trasferito alla scuola truppe corazzate, e infine dal Friuli, ormai sottotenente dei Lancieri di Novara; io gli rispondevo da Roma e nelle nostre lettere ripassavamo i programmi, facevamo riflessioni sui materiali, ci caricavamo a vicenda; insomma quel punto interrogativo ci aveva stregati.
Entrammo decisi: il primo saltino, il “bicchiere”, il secondo salto, furono superati celermente e ci ritrovammo al punto della nostra ritirata di due anni prima.
Il canotto conteneva a malapena uno solo di noi; dovevamo a tutti i costi limitare il peso dei materiali e ce ne eravamo procurato pertanto uno piccolissimo. Con una lunga sagola di richiamo passammo a turno i laghi e raggiungemmo la prima grande sala concrezionata.
Un breve riposo e, usando il canottino come contenitore per i materiali, proseguimmo arrivando allo pseudo-sifone. Fummo costretti a bagnarci completamente: c’era molta acqua e la volta della grotta che si abbassava ne toccava quasi il pelo. Stando a bordo del canotto non c’era spazio sufficiente per passare, ci immergemmo fino al naso e ci trascinammo dietro il canottino che faceva resistenza strusciando sotto la volta.
Non avevamo mute di gomma naturalmente, né di neoprene e l’acqua era fredda, ma la determinazione era tanta e proseguimmo ansiosi: saltini, laghetti, passaggi in roccia, marmitte.
La galleria era stretta ma molto alta, tenevamo ben presenti tutti i punti di risalita in caso di necessità, ma lo facevamo più per buona tecnica d’avanzata che per reale bisogno, sapevamo infatti che il tempo fuori era buono.
Ormai eravamo vicini al nostro traguardo. Che sorpresa ci avrebbe riservato la grotta appena poco più in là? Dovevamo esserci ormai!
Il percorso si fece ancora più stretto e levigato, sembrava una condotta forzata ed …… ecco cos’era, maledizione!
Nell’oscurità profonda della galleria, le cui pareti, allargandosi in avanti improvvisamente, non riuscivamo più ad illuminare né con le luci frontali, né con le acetilene, si aprì ai nostri piedi un gran salto di cui non vedevamo il fondo.
Ecco cos’era il punto interrogativo: un salto! E perchè non lo avevano segnato su quella benedetta piantina? Certamente chi aveva fatto il rilievo doveva pure esserci arrivato.
In effetti il “punto interrogativo” lo avevamo lasciato alle nostre spalle di una trentina di metri e, senza avvedercene, avevamo superato apparentemente il punto massimo riportato nel rilievo della scheda.
Ma allora quel salto eravamo i primi a vederlo? Ci affacciammo con cautela dalla galleria il cui fondo liscio e scivoloso si apriva di netto sul vuoto. Ormai potevamo prendere fiato.
Capimmo subito che lì era finita la nostra esplorazione: avevamo ancora una scaletta ma in tutto copriva solo 15 metri, non saremmo passati mai!
Tirai allora fuori il mio famoso faro e con quello arrivammo a vedere particolari in basso ed in avanti della sala che proseguiva effettivamente alta e misteriosa.
Stimammo l’altezza del salto in 25-30 metri; sarebbe servito per la volta successiva.
Eravamo contenti e orgogliosi anche se delusi: ad un salto di quelle dimensioni non avevamo pensato.
Avevamo però dimostrato che in due, solo in due, era stato possibile raggiungere quel punto e che tutto il timore reverenziale per quella grotta, che ne faceva escludere dal Circolo persino i programmi di esplorazione era, in buona parte, infondato.
Tornammo indietro con calma, non perdemmo nulla, disarmammo i salti, sgonfiammo il canotto e riguadagnammo il maestoso antro d’ingresso della “nostra grotta”.
Era a mezzo della notte ed avemmo il meritato premio: la luna piena, ferma nel cielo di fronte a noi, inondava di luce l’alta valle di Luppa.
Bagnati e felici ci sdraiammo su un prato e dividemmo finalmente una scatoletta di tonno. Il resto della notte lo passammo nel fienile di una casa colonica vicina.
Scendendo la mattina successiva da Pietrasecca verso Carsoli, per la vecchia strada bianca che correva sotto i boschi di castagni (strada attualmente abbandonata, per la costruzione da anni della variante della Tiburtina-Valeria, che passa proprio di fronte a Luppa), la Lambretta, per il carico sbilanciato, perse il suo assetto e finimmo per terra.
Cadendo arammo il brecciolino con il palmo delle mani e riportammo ferite che si rimarginarono più di un mese dopo.
Giorgio che aveva le mani ridotte peggio delle mie, fu molto bravo nel riportare la Lambretta a Roma, ma venne da sé che aumentò un poco il nostro disappunto per non aver potuto adoperare la jeep del Circolo.
Ai giovani soci il suo uso era interdetto, anche se Giorgio in particolare, per un anno intero, durante la sua permanenza, come sottotenente dei Lancieri di Novara, in una unità corazzata, non aveva fatto altro che guidare mezzi identici.
Con un primo pomeriggio pieno di sole, arrivammo in una Roma semideserta e dirigemmo senza indugi a casa di Marcello Cerruti.
La fiducia che ci aveva accordato e indubbiamente una certa preoccupazione per la nostra sorte che pensavamo dovesse avere, consigliavano che gli dessimo, al più presto e per primo, la notizia del nostro piccolo successo.
Ricordo che, mentre nel suo studio gli raccontavamo i particolari dei due giorni precedenti, ci medicò le mani e con una lunga pinzetta ci asportò una miriade di sassetti rimasti nelle ferite.

Luppa 1960
Speravamo che con la nostra ricognizione si potesse avviare la definitiva esplorazione della grotta in un clima di rinnovamento della tecnica e della mentalità speleologica.
Ma erano speranze un po’ velleitarie, giustificate dall’entusiasmo della nostra giovane età che non teneva e non poteva tener conto delle resistenze che avrebbe provocato in chi aveva abitudini e prassi ormai consolidate da tempo.
Infatti la nostra iniziativa innescò lentamente tutta una serie di contrasti interni tra soci giovani e anziani che, invece di portare ad una coesione di intenti, originò prese di posizioni laceranti che alla fine concorsero alla fondazione dello Speleo Club Roma nel 1959.
Fu l’ennesima edizione del solito conflitto di generazioni. Da un lato una parte di soci “anziani”, pur avendo rapporti personali cordiali e affettuosi con tutti, non riuscirono a comprendere che la gestione di un’associazione, sportiva e di potenziale ricerca scientifica, doveva essere condotta con maggiore aderenza ai tempi che mutavano velocemente.
Il Circolo Speleologico Romano sembrava che fosse, per molti di loro, una entità strettamente personale, da non dividere troppo con altri; che dava lustro, ma senza grossi impegni.
Da un altro lato molti dei soci “giovani” scalpitavano e non riuscirono ad avere la pazienza di aspettare che, con la loro spinta, si arrivasse ad una conduzione del Circolo moderna, agile, seria con responsabilità estese a chi effettivamente faceva attività e si impegnava nella ricerca.
Luppa nel frattempo continuò ad essere frequentata dai giovani con tecniche di avanzamento più agili e gradualmente con il sussidio di materiali moderni.
Almeno questo non fu più possibile impedirlo e piano piano ne fu completata l’esplorazione.
La “provocazione” che attuammo Giorgio ed io nel ‘55 andò pertanto oltre i fatti specifici di quella grotta; senza che ci potessimo rendere conto delle conseguenze finali, mise in moto un ingranaggio alimentato dalla scontentezza e dall’energia di altri compagni arrivati al Circolo dopo di noi, ingranaggio che non fu possibile fermare e che, tutto sommato, ferì tutti.
Le dimissioni di dodici giovani dal Circolo Speleologico Romano, che formarono la base dei quattordici soci fondatori dello Speleo Club Roma, non avvennero senza rimpianti sia per chi andò via, sia per chi rimase.
Io personalmente, che all’epoca facevo parte della SUCAI-ROMA, proposi di creare, a simiglianza del Club Alpino, una sezione universitaria nell’ambito del Circolo Speleologico che avesse, come per la SUCAI, un suo spazio parallelo e indipendente.
Non convinsi nessuno.
E così quel punto interrogativo portò a termine il suo lavoro. Chissà … se Giorgio ed io non avessimo trovato la scheda della grotta di Luppa ……
Ma i “chissà” non hanno valore e pertanto, complice e pronuba una birreria di via Simeto che ospitò, nella memorabile sera del 5 dicembre 1958, i transfughi con i loro sostenitori, lo Speleo Club Roma prese il volo.
Prese il volo con le bianche ali del pipistrello del suo distintivo che ebbi l’onore e il piacere di disegnare e che così furono motivate e giustificate dalla esuberante immodestia che subito caratterizzò la nuova mentalità del gruppo: “Tutti sono capaci di essere pipistrelli neri; solo noi dello Speleo Club Roma saremo pipistrelli bianchi!”
Quanto eravamo giovani!
Italo Bertolani
Roma, 5 maggio 1988



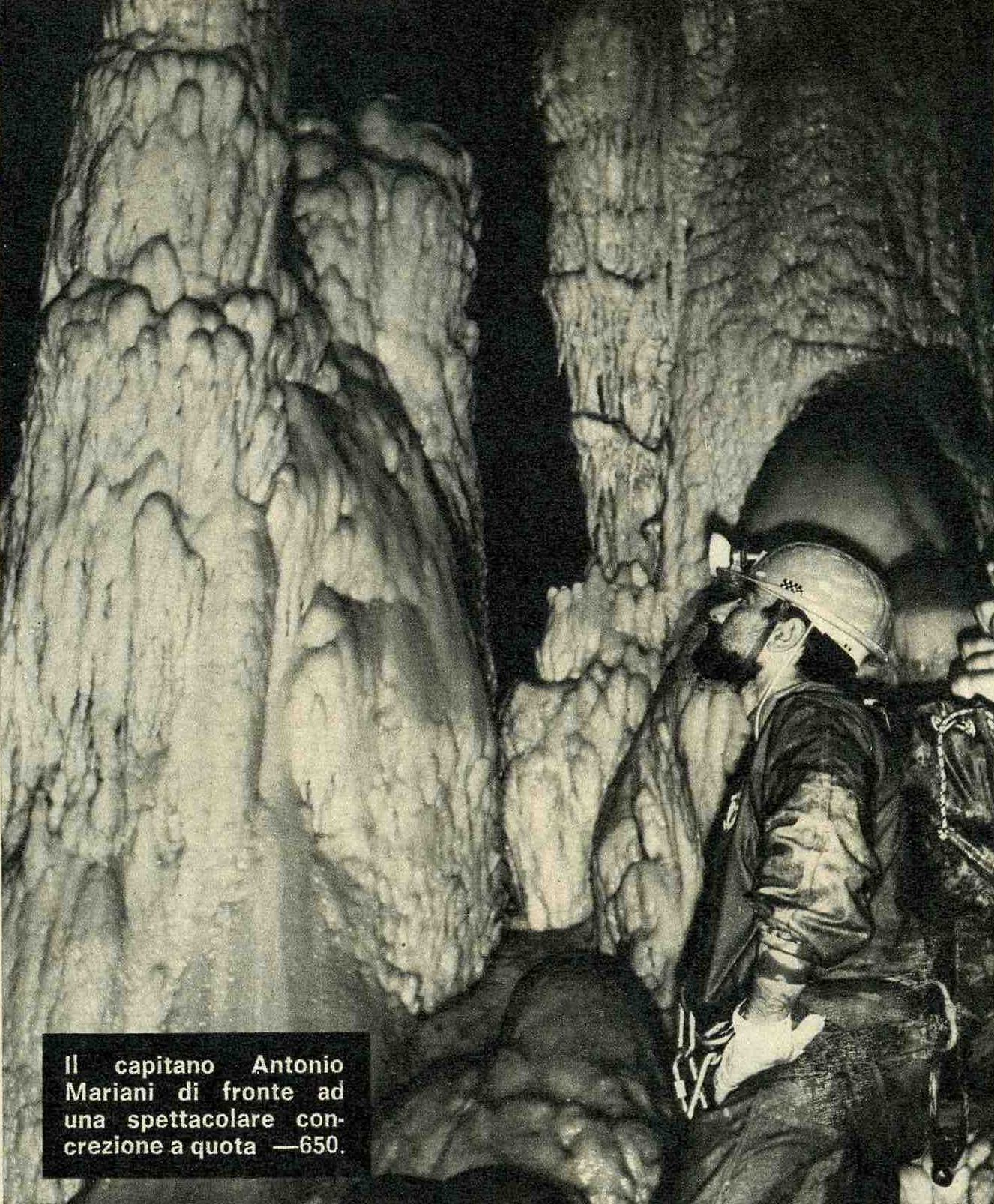


Scrivi un commento